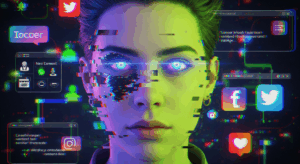Multimedialità e Transmedialità: raccontare, abitare, disinnescare i media
Reading Time: 5 minutesViviamo in un’epoca in cui i linguaggi si moltiplicano, ma il senso rischia di perdersi. Questo articolo esplora le differenze tra multimedialità e transmedialità, andando oltre la superficie dei media digitali per affrontare i meccanismi profondi del racconto contemporaneo. Un viaggio tra tecnologie, estetiche e ideologie, dal branding culturale dei grandi franchise all’esperienza radiofonica come spazio libero. Con riferimenti interni agli articoli di Radio Atlantide e una sezione dedicata al concetto di “vuoto come metodo”, il testo invita a un dibattito sulla narrazione come atto politico e spazio di possibilità. Un’esplorazione lunga, densa e pensata per aprire varchi, non per chiuderli.
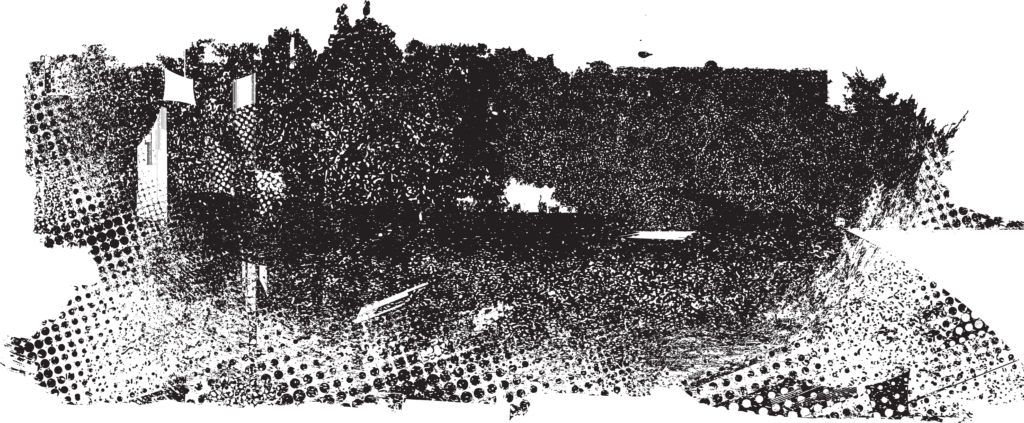
Intro — Il mondo raccontato troppe volte
Tutto è racconto. Ma tutto, oggi, sembra raccontato troppe volte.
Una canzone diventa un video, poi un reel, poi un making of, poi un meme, poi una maglietta, poi una serie. Una notizia è prima una notifica, poi un carosello Instagram, poi un podcast, poi un TikTok. Ma non sappiamo più da dove cominciare. O peggio: non ci chiediamo più perché tutto debba cominciare da qualche parte.
In un vecchio articolo intitolato Are We Not Men? We Are Devo! abbiamo detto che la trasformazione digitale ha rotto ogni barriera tra contenuto e contenitore, tra artista e medium. Siamo diventati il nostro media. E i media non raccontano più il mondo: lo producono.
La nostra identità è sempre più il riflesso di una timeline. La nostra memoria, un archivio esterno.
Allora, parlare di multimedialità e transmedialità non è una questione accademica, ma un atto di conservazione. Perché i formati, oggi, non sono neutri. Sono ideologici. E ogni racconto è un campo di battaglia.
Lo specchio e la trappola: la multimedialità
La multimedialità è la logica della convergenza apparente. Prendi un contenuto, lo esprimi in più linguaggi – testo, immagine, audio, video – e lo metti nello stesso contenitore. L’obiettivo è amplificare il messaggio, renderlo più accessibile, più attrattivo, più completo. Ma la struttura è verticale: il centro è uno, i linguaggi sono servi.
È la logica del museo interattivo, del CD-ROM educativo, del sito web di una mostra che racconta con la voce, con le foto, con le animazioni, ma racconta sempre la stessa cosa. E oggi la troviamo ovunque: nei giornali digitali, nelle piattaforme educative, nelle narrazioni corporate. È utile, è potente, ma spesso è anche una trappola.
Perché l’apparente ricchezza sensoriale nasconde una povertà epistemologica.
Nel pezzo L’era biomediatica abbiamo scritto che oggi i media non si limitano a trasmettere contenuti: modellano comportamenti.
La multimedialità diventa così uno spazio guidato, una visita obbligata, una UX perfetta in cui non puoi sbagliare. Ma se non puoi sbagliare, non puoi nemmeno scoprire davvero. Sei immerso, sì. Ma in uno spazio chiuso, disegnato per te.

Espandere o replicare? Il doppio volto della transmedialità
La transmedialità, invece, promette orizzonti. È la narrazione espansa, la storia che si dipana su più media, ogni volta con un frammento diverso, con un linguaggio diverso, con un punto di vista inedito. Non replica, ma moltiplica. Non rafforza un messaggio centrale, ma lo dissemina. In teoria.
Sì, in teoria perché la transmedialità, pur apparendo come una forma di partecipazione espansa, è spesso, se non ormai sempre, strumento di capitalismo culturale.
In pratica, troppo spesso la transmedialità è diventata una strategia di mercato. Un universo narrativo che ti cattura, ti fidelizza, ti monetizza. Ogni nuova piattaforma è una soglia, ma anche un cancello. Se non lo attraversi, ti perdi qualcosa.
Se non segui tutto, sei fuori.
Pensiamo a franchise come Marvel, Star Wars, Stranger Things: film, serie, videogiochi, fumetti, podcast, live experience. Tutto è narrazione. Ma anche tutto è branding.
Lo storytelling transmediale, nato come atto creativo, è stato assorbito dalla macchina delle IP: proprietà intellettuali gestite come licenze, con una narrazione centralizzata, controllata, supervisionata.
E allora la domanda è: espandiamo o replichiamo? Esploriamo o colonizziamo?
Radio Atlantide, tra voce e spazio
Nel nostro articolo La radio era libera, abbiamo raccontato cosa significa per noi usare la radio non come format, ma come spazio. Uno spazio non lineare, non algoritmico, non predittivo. Un luogo dove la voce rompe i tempi, dove una canzone apre un varco, dove una citazione non è un “contenuto”, ma un invito.
Questo spazio è l’antitesi delle logiche chiuse della multimedialità. È l’ecosistema narrativo che non vuole trattenerti, ma aprirti. È l’unica forma di transmedialità che ci interessa: quella che crea fratture, che accetta il rischio, che lascia vuoti. Definiamola “transmedialità buona“
Narrare è rischiare
Ogni narrazione è una scelta. Puoi raccontare per vendere. Puoi raccontare per convincere. Puoi raccontare per trattenere.
Oppure puoi raccontare per cercare, per perdere, per aprire. Puoi narrare per rischiare di non essere capito.
L’analfabetismo funzionale è diventato norma. Lo sappiamo. Ma non è abbassando il livello che si resiste.
È scommettendo sulla complessità. È creando testi che si leggono in quindici minuti, ma restano in testa per giorni. È seminando domande, non risposte.
E forse proprio questa è la vera transmedialità buona: una narrazione che si interrompe, che ti espone, che ti costringe a cercare altrove. Non un universo chiuso, ma una mappa incompleta. Non un tunnel, ma una ferita sempre aperta.
Linkare per aprire (internamente)
Quando parliamo di transmedialità buona, non intendiamo solo disseminare contenuti su più piattaforme, ma costruire una rete di senso, non lineare, non gerarchica, che permetta al lettore di muoversi liberamente. Per questo i collegamenti tra i nostri articoli non sono decorativi, ma porte aperte verso approfondimenti che completano, contraddicono, amplificano quanto qui viene detto.
➤ “Are We Not Men? We Are Devo”
In questo articolo, l’identità diventa medium. Non si parla solo di una band, ma di come un’intera estetica – musicale, visiva, concettuale – possa incarnare un’idea politica e culturale. DEVO non è un gruppo, è un sistema narrativo. Un’esperienza multimediale e transmediale ante litteram, che anticipa l’epoca in cui le persone stesse diventano brand e contenuto. Un pezzo fondamentale per comprendere come la forma del racconto influenzi la percezione della realtà.
📎 Leggi qui
➤ “L’era biomediatica”
Qui si esplora la trasformazione del rapporto tra corpo e media. I dispositivi non sono più esterni a noi: sono protesi cognitive, emozionali, identitarie. I social non mediano solo comunicazione, ma producono comportamenti. È un punto cruciale per comprendere il passaggio dalla multimedialità (che amplifica) alla transmedialità (che struttura esperienze immersive e totalizzanti). Questo articolo è una chiave di lettura per chi vuole indagare l’effetto che i formati narrativi hanno sul nostro modo di essere nel mondo.
📎 Leggi qui
➤ “La vera storia della piccola C.A.T.I.”
Una riflessione autobiografica e storica su cosa significava fare radio prima che diventasse una piattaforma. Quando ogni programma era un gesto irripetibile, quando la voce era presenza reale e non un prodotto da scaletta. Un testo che aiuta a capire perché Radio Atlantide non segue l’algoritmo: non cerca di piacere a tutti, ma di parlare a chi ascolta davvero.
📎 Leggi qui
🌀 Il vuoto come metodo
Il concetto di vuoto, inteso non come assenza ma come spazio generativo, è una costante silenziosa nelle pratiche culturali più radicali. Sui nostri canali lo abbiamo esplorato in varie forme, dalla riflessione sul suono, al gesto radiofonico, fino all’estetica dell’imperfezione.
Un elogio dell’incompiuto e dell’irregolare, indagando le potenzialità comunicative del non detto e dell’interruzione come stile.
Nel pensiero giapponese tradizionale esiste il concetto di ma (間): uno spazio-tempo interstiziale, un vuoto significativo tra due cose, che non è assenza ma presenza del possibile. È ciò che rende la musica respirabile, una pausa eloquente, una porta socchiusa anziché sbattuta. Così anche nella narrazione: un racconto che lascia spazio all’ascoltatore per abitare il senso, per completarlo con sé stesso.
Nel mondo dell’arte, pensiamo all’“Esposizione Internazionale del Niente” del 1960 – ideata da Piero Manzoni e altri artisti concettuali – che ridefiniva l’opera come assenza, come provocazione, come spazio di proiezione. In un certo senso, transmedialità buona è anche questo: non saturare, ma evocare.
Nel nostro articolo La vera storia della piccola C.A.T.I. la radio era descritta come quel vuoto che ti accoglie tra una parola e l’altra. E nel pezzo Are We Not Men? We Are Devo, è proprio nel “vuoto di senso” generato dalla disumanizzazione estetica che si apre uno spiraglio critico.
Il vuoto, dunque, non è un errore. È metodo.
Conclusione — Non tutto deve tornare
Multimedialità e Transmedialità non sono solo tecniche: sono sintomi. Ci dicono come pensiamo, come progettiamo, come viviamo. Dobbiamo prestare sempre la nostra massima attenzione critica se non vogliamo essere travolti.
Ma possiamo usarle contro se stesse. Possiamo raccontare contro il formato, contro l’algoritmo, contro la fidelizzazione.
Non tutto deve tornare. Non tutto deve concludersi. Non tutto deve avere una risposta.
La vera rivoluzione oggi è lasciare dei vuoti.
E se quei vuoti portano qualcun altro a raccontare, allora sì, quella è transmedialità buona.
SCARICA IL SAGGIO GRATUITO DI QUESTO ARTICOLO