Musica senza significato? Una riflessione su ciò che abbiamo perso
Reading Time: 4 minutesCosa è successo alla musica? Perché non la ascoltiamo più davvero, ma la usiamo come sottofondo neutro e innocuo? Un viaggio tra cinque piani interconnessi — cultura, media, economia, attenzione e simboli — per capire come la musica ha perso centralità nella nostra vita. Un’introduzione che è anche un invito a ritrovare il senso dell’ascolto.
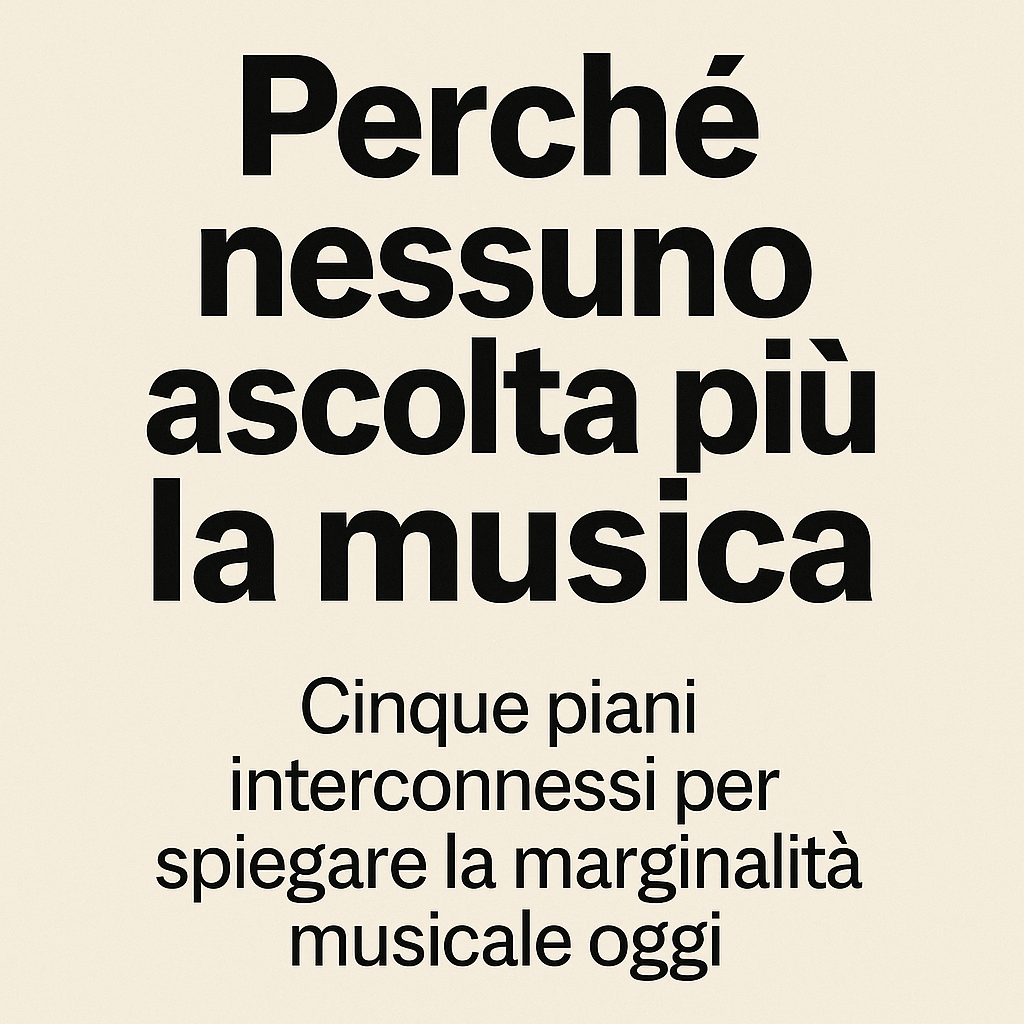
Immagine generata con AI
Perché oggi la musica è vissuta quasi esclusivamente come sottofondo innocuo o intrattenimento da “scrollare”? Cinque spunti per un’indagine sul senso perduto della musica e su come (forse) ritrovarlo.
INTRODUZIONE
C’è stato un tempo in cui la musica poteva dividere le famiglie, accendere le piazze, far tremare i governi. Un tempo in cui un disco non era solo un prodotto, ma una dichiarazione d’intenti, un luogo mentale, un rito collettivo. Oggi, nella maggior parte dei casi, la musica fa compagnia durante lo shopping, alleggerisce una call, tiene il ritmo in palestra o si disperde nei reel di Instagram. Resta viva nei circuiti alternativi, certo, ma sembra avere perso il suo ruolo centrale nel plasmare identità, creare comunità, dare voce ai conflitti.
Perché è successo? Quali dinamiche hanno portato la musica a diventare quasi invisibile nella vita culturale e politica? E cosa ci dice questa trasformazione del nostro rapporto con il tempo, il linguaggio, l’immaginario?
In questa prima parte di un percorso a tappe, proponiamo cinque direttrici critiche per orientarsi. Ognuna diventerà, nei prossimi articoli, oggetto di un approfondimento specifico.
1. Dalla musica come linguaggio alla musica come ambiente
Negli anni Sessanta e Settanta, la musica era spesso molto più di un semplice accompagnamento sonoro. Parlava di guerra e di pace, di sessualità, razzismo, lavoro, utopie, rabbia. Certo, non mancava chi cercava soprattutto un ritmo, un ballo, una distrazione, ma in molti casi l’ascolto era anche un gesto identitario, quasi politico.
Oggi la musica è sempre più un ambiente sonoro: una cornice, un mood, un sottofondo. Le canzoni non si ascoltano per essere cambiate, ma per accompagnare un’attività: studio, camminata, scroll.
È la transizione da musica significante a musica funzionale. Il passaggio da evento a servizio.
Per cogliere cosa intendiamo per musica come linguaggio, si ascolti “Dio è morto” di Francesco Guccini, che nel 1967 “osava” parlare di disillusione, materialismo e ricerca di senso in un’Italia ancora profondamente cattolica.
E per cogliere invece il progressivo disimpegno leggero, “Una zebra a pois“ di Mina può rappresentare il gusto per l’evasione spensierata e l’assurdo ironico — non priva di fascino, ma distante anni luce dalla carica simbolica e sociale del cantautorato.
2. Il dominio dell’algoritmo: lo streaming come forma di consumo passivo
Spotify, YouTube Music, TikTok: strumenti potentissimi ma anche responsabili di un ascolto spesso distratto, frammentato, addomesticato. Gli algoritmi non sempre premiano la complessità, ma quasi sempre la riconoscibilità. Brani brevi, ripetitivi, adattabili a mood precostituiti. Il risultato? Una marea di canzoni simili, facilmente intercambiabili, che spesso mancano di personalità o profondità.
Non si colleziona più musica, non si aspetta, non si desidera: si consuma. Anche se è pur vero che queste piattaforme, a volte, permettono anche scoperte sorprendenti. Ma ci vuole consapevolezza.
In un’epoca in cui i brani vengono selezionati da playlist algoritmiche e scorrono senza volto, canzoni come “Ognuno è libero” di Luigi Tenco ci ricordano che anche una melodia semplice può portare con sé un messaggio potente, se ascoltata con attenzione e consapevolezza.
3. I media generalisti hanno smesso di raccontare la musica
Oggi la musica compare nei notiziari solo quando un cantante muore o partecipa a un talent. Le trasmissioni televisive musicali sono quasi scomparse. Le radio commerciali ripetono un numero ridotto di hit all’infinito. La critica musicale sopravvive in nicchie digitali, spesso prive di visibilità presso il grande pubblico.
La musica non viene più narrata, decifrata, contestualizzata. E quando manca la narrazione, svanisce anche la percezione del valore. Anche se alcune realtà indipendenti resistono, producendo contenuti culturali di rilievo.
4. L’attenzione è la nuova scarsità: la fine dell’ascolto attivo
In un mondo dove tutto compete per attirare attenzione, l’ascolto musicale è diventato spesso una pratica secondaria. La musica viene saltata, skippata, interrotta da notifiche, pubblicità, cambi d’umore. Un tempo l’ascolto poteva essere un gesto deliberato: mettere su un vinile, sedersi, lasciarsi coinvolgere.
Oggi è più spesso un flusso, che raramente riesce a farsi evento. Anche se, per molti appassionati, momenti di ascolto dedicato esistono ancora e resistono, proprio perché diventati più rari e preziosi.
Riascoltare oggi una canzone come “Eve of Destruction” di Barry McGuire ci costringe a rallentare, a prestare attenzione a ogni parola. È una canzone-manifesto, impossibile da mettere in sottofondo. E proprio per questo, ancora oggi, disturbante e necessaria.
5. Il vuoto simbolico: la musica non costruisce più immaginari
Cosa racconta oggi la musica pop dominante? Spesso, molto poco. Parla di sentimenti generici, emozioni neutre, desideri individuali. Non costruisce un “noi”, non produce futuro. E non è un caso: l’industria ha neutralizzato molte forme di devianza, conflitto, radicalità. La musica mainstream tende a essere progettata per piacere a tutti, quindi per non dire nulla di troppo preciso.
Ma la musica senza simboli è come una lingua senza grammatica. Anche se negli spazi indipendenti, underground o sperimentali, nuovi immaginari continuano a nascere.
Verso i prossimi articoli
Nei prossimi approfondimenti entreremo nel dettaglio di ciascuno di questi punti:
- Il passaggio dalla musica come linguaggio alla musica come ambiente (con riferimenti storici e sociologici)
- Lo streaming e l’ascolto algoritmico come nuova forma di consumo culturale
- L’estinzione della narrazione musicale nei media tradizionali
- Il tempo, l’attenzione e l’erosione dell’ascolto attivo
- Il vuoto simbolico della musica commerciale e le resistenze alternative
Ogni articolo conterrà esempi, casi studio, e soprattutto domande per riaccendere il pensiero critico attorno alla musica.
Perché no, non è vero che la musica non interessa più a nessuno.
Ma è vero che abbiamo dimenticato perché dovrebbe importarci.

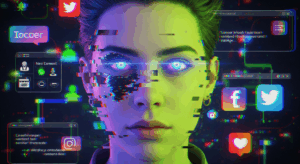


1 thought on “Musica senza significato? Una riflessione su ciò che abbiamo perso”
Comments are closed.