Prima del rumore: Voci queer prima di Stonewall
Reading Time: 5 minutesPrima di Stonewall, prima dei pride, prima persino della parola “queer”, c’erano voci. Voci nere, coraggiose, sensuali. Da Ma Rainey a Gladys Bentley, passando per Bessie Smith e Billy Strayhorn, questo articolo racconta come la musica afroamericana tra gli anni ’20 e ’60 abbia nascosto e rivelato le identità LGBTQ+ in un mondo ostile. Un viaggio tra blues, Harlem Renaissance e vocalità ribelli, dove il desiderio suona tra le righe e le crepe nel silenzio diventano ritmo.

Portrait of Bessie Smith Abstract/medium
Nota sui termini
In questo progetto useremo il termine “queer” per indicare modalità espressive e identitarie che sfidano le norme di genere e sessualità, soprattutto quando si parla di ambiguità deliberata, fluidità e rottura dei codici dominanti. Tuttavia, siamo consapevoli che “queer” non rappresenta automaticamente tutte le soggettività LGBTQ+ e non sostituisce in alcun modo le identità gay, lesbiche, bisessuali, trans, intersex, asessuali o non binarie.
Quando possibile, useremo termini più precisi e storicamente contestualizzati, rispettando l’autodefinizione delle persone e dei movimenti di cui si parla. Questa scelta nasce dalla volontà di valorizzare la pluralità delle voci e delle esperienze, evitando ogni cancellazione o semplificazione.
Il blues sotto il trucco, l’ambiguità nascosta nei solchi
In un juke joint del Mississippi, mentre fuori la segregazione razziale scandisce la legge, dentro una voce roca canta d’amore per una donna… ed è un’altra donna a cantare. Non lo dice apertamente, ma chi sa, capisce.
“Went out last night with a crowd of my friends, they must’ve been women, ‘cause I don’t like no men.” (Ma Rainey, Prove It On Me Blues, 1928)
Traduzione: “Sono uscita ieri sera con un gruppo di amici, dovevano essere donne, perché gli uomini proprio non mi piacciono.“
In un’America che perseguita i corpi neri e i desideri non conformi, la musica diventa il nascondiglio perfetto: abbastanza rumorosa da coprire la verità, abbastanza viva da farla brillare tra le righe.
Contesto storico e sociale
Tra gli anni ’20 e la fine degli anni ’60, negli Stati Uniti l’omosessualità è criminalizzata, punita dalla legge e bollata come patologia mentale fino al 1973.
L’apartheid razziale permea ogni aspetto della vita pubblica e privata. Le leggi Jim Crow nel Sud e le forme più subdole di segregazione nel Nord marginalizzano le persone afroamericane nei trasporti, nel lavoro, nei diritti civili e nell’accesso agli spazi pubblici.
Nel contesto urbano di città come New York, Chicago e New Orleans, tuttavia, si formano microcosmi alternativi dove le regole dominanti possono essere temporaneamente sospese.
La musica nera – in particolare il blues, il jazz e il gospel – diventa uno spazio di elaborazione culturale collettiva, capace di contenere le tensioni tra desiderio, vergogna, rivolta e sogno.
Gli artisti afroamericani queer operano in un sistema a doppia marginalità: oppressi per il colore della pelle e per la non conformità sessuale o di genere. Tuttavia, proprio questa posizione di confine rende la loro arte un terreno fertile per l’invenzione di nuovi linguaggi.
Così nasce il linguaggio in codice: metafore, doppi sensi, ambiguità, storie mimetiche. C’è una grammatica queer che precede la parola “queer”, e che abita le pieghe di un’espressione musicale che è, per sua natura, non normativa. Il blues non giudica: racconta, sussurra, grida, allude. E proprio in quell’allusione si annida un gesto radicale. metafore, doppi sensi, ambiguità, storie mimetiche.
Harlem Renaissance e la cultura queer afroamericana
Negli anni ’20 e ’30, Harlem diventa un polo di fermento artistico, culturale e politico per la comunità nera americana. Pittori, poeti, musicisti e intellettuali convergono in quello che viene definito Harlem Renaissance.
In questo contesto, la cultura queer trova una delle sue prime forme pubbliche di espressione, seppur ancora marginale.
Club come il Clam House e il Gladys’s, gestiti da e per persone LGBTQ+, diventano spazi di libertà notturna.
Figure come Langston Hughes, Richard Bruce Nugent e Alain Locke portano avanti un’estetica black queer fatta di bellezza, sensualità e sfida ai codici normativi.
È in questi luoghi che prendono voce molti degli artisti citati in questo articolo.
Le protagoniste del blues queer
Ma Rainey è forse la prima vera matriarca del blues nero e queer.
Il suo brano del 1928, Prove It On Me Blues, è una dichiarazione non dichiarata: “Dicono che vado in giro con donne, ma a me non importa… Se non mi credi, provamelo.” Un testo allusivo, sfacciato, impossibile da ignorare.
Bessie Smith, sua allieva e amica, è regina del dolore e del desiderio.
Si racconta che fosse apertamente bisessuale nel suo ambiente, protetta dalla sua fama. La sua voce – potente, profonda, sensuale – è un atto d’identità più che d’esibizione. In Young Woman’s Blues, canta la libertà femminile con una consapevolezza che sfida il patriarcato e i suoi moralismi.
Gladys Bentley, in frac e papillon, canta e suona il piano nei bar di Harlem durante il Rinascimento nero.
Mascolina, carismatica, dichiaratamente lesbica, viene idolatrata dal pubblico queer afroamericano, ma perseguitata dalla stampa e dalla polizia. È un’icona prima del tempo, un crocevia di resistenza e spettacolo.
Billy Strayhorn, arrangiatore di fiducia di Duke Ellington, è forse il più “invisibile” dei quattro.
Gay e raffinato, autore del capolavoro Lush Life, rimane nell’ombra per buona parte della sua carriera. Ma la sua musica trasuda malinconia queer, come un segreto sussurrato in una sala fumosa.
Lucille Bogan, meno citata ma decisiva, incide negli anni ’30 brani di un erotismo diretto e talvolta esplicitamente queer, come BD Woman’s Blues (“bulldagger” era slang per lesbica mascolina). Con uno stile grezzo e un lessico crudo, porta la sessualità queer nel cuore del blues rurale.
Alberta Hunter, cantante jazz e blues, ha vissuto gran parte della sua vita personale lontano dai riflettori, ma si è saputo che ebbe relazioni con donne.
La sua eleganza e il controllo vocale fanno da contrappunto all’intensità viscerale di altre coeve, ma la sua identità queer ha lasciato un’impronta nelle sotto-tracce della sua lunga carriera.
Il corpo e la voce come maschera e verità
In un mondo che non ti lascia esistere, il corpo e la voce diventano le prime maschere e le prime verità. I travestimenti scenici di Bentley, il falsetto liberatorio di certi cantanti gospel, le voci androgine o iper-femminili: tutto diventa codifica.
Prima ancora che il termine “queer” entri nel vocabolario della rivendicazione, esiste una voce queer. Non sempre dice, ma sempre mostra. Frattura i codici vocali del maschile e del femminile, infonde desiderio dove il mondo vuole vergogna. La voce queer è una crepa nel silenzio.
In una società che puniva il corpo deviato, molti artisti hanno fatto della performance una zona di trasformazione. Il corpo travestito, camuffato, eccedente, è diventato un linguaggio. Gladys Bentley con il suo tuxedo ribaltava lo stereotipo della donna nera sessualizzata. Lucille Bogan cantava l’eros lesbico senza filtro, mentre Alberta Hunter lo faceva filtrare attraverso il controllo elegante della sua presenza.

La voce, più del corpo, può diventare un’arma invisibile. Il timbro profondo di Ma Rainey, il vibrato dolente di Bessie Smith, l’eleganza raffinata di Strayhorn: tutti questi elementi veicolano identità queer senza nominarle. È una forma di attivismo pre-politico: l’esistenza attraverso il suono.
Questa vocalità non conforme anticipa la genealogia di voci queer che arriva fino a oggi, passando per Nina Simone, Prince, Anohni, Arca.Tutte voci che rompono i margini e interrogano chi ascolta: chi canta? E da dove, e per chi?
L’eredità che (non) sappiamo di conoscere
Molte delle icone LGBTQ+ di oggi – da Janelle Monáe ad Anohni, da Big Freedia a Mykki Blanco – sono figlie di una genealogia spesso dimenticata. Il blues queer degli anni ’20-’40 non è solo una curiosità storica, è la radice profonda di una cultura che ha imparato a trasformare l’emarginazione in stile, e la vergogna in potenza.
La cultura pop ha spesso “ripulito” queste figure, omettendo il loro orientamento o identità di genere. Le ha eterosessualizzate, neutralizzate, archiviate in un limbo nostalgico. Rileggere i solchi, oggi, è un atto politico e affettivo. Una forma di giustizia musicale.
Playlist essenziale
- “Prove It On Me Blues” – Ma Rainey
- “Young Woman’s Blues” – Bessie Smith
- “Let’s Have a Party” – Gladys Bentley
- “Lush Life” – Billy Strayhorn (con Nat King Cole o Ella Fitzgerald)
- “I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter” – Fats Waller (riletto queer)
- “BD Woman’s Blues” – Lucille Bogan
- “You Can’t Tell the Difference After Dark” – Alberta Hunter
La Grande migrazione e il Rinascimento di Harlem
Prima di chiudere, ti invito a guardare questo video che racconta le radici culturali e storiche della Harlem Renaissance e più in generale per un approfondimento storico culturale di quel periodo.
Un punto di partenza fondamentale per comprendere la forza dirompente della musica afroamericana negli anni ’20 e ’30, e il terreno fertile in cui sono nate molte delle voci che raccontiamo.

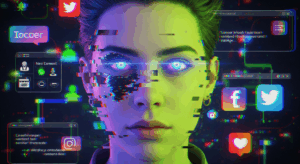


3 thoughts on “Prima del rumore: Voci queer prima di Stonewall”
Comments are closed.