INTRODUZIONE: 1976 – L’ANNO ZERO DELLE RADIO LIBERE
Reading Time: 5 minutesIl 1976 segna l’anno zero delle radio libere italiane con la storica sentenza 202 della Corte Costituzionale che spezza il monopolio RAI. Ma la rivoluzione era già in corso: dalle prime esperienze “pirata” come Radio Sicilia Libera di Danilo Dolci (1970) a Telebiella di Peppo Sacchi (1972), fino alla Radio Bologna per l’accesso pubblico di Roberto Faenza (1974) che anticipa Radio Alice.
Una storia di pionieri, battaglie legali e roulotte sui colli bolognesi che cambierà per sempre il paesaggio sonoro italiano. In soli due anni, dall’apertura dell’etere, le radio libere passano da 400 a 2800, introducendo telefonate in diretta, stereofonia e comunicazione orizzontale.
Due anime emergono subito: quella politico-culturale che vuole “dare voce a chi non ce l’ha” e quella imprenditoriale che vede nel nuovo etere un’opportunità commerciale. Ma nel 1976 quello che conta è una cosa sola: l’etere è finalmente libero.

Foto di <a href="https://unsplash.com/it/@indraprojects?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Indra Projects</a> su <a href="https://unsplash.com/it/foto/una-radio-seduta-sopra-un-tavolo-di-legno-taJZSnvFILg?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>
Il 1976 non segna l’inizio della radio libera in Italia, ma piuttosto un momento di svolta legale e simbolica che cambia per sempre il paesaggio sonoro del Paese. Già prima della storica sentenza 202 della Corte Costituzionale del 28 luglio 1976, l’etere italiano era attraversato da esperienze spontanee, non autorizzate, spesso effimere ma ricche di significato.
L’Italia prima della libertà: monopolio e fermenti
Dal 1924, anno della prima trasmissione regolare dell’Unione Radiofonica Italiana (poi diventata RAI), fino al 1976, il monopolio statale sulle comunicazioni radiofoniche era assoluto. L’articolo 195 del codice postale vietava categoricamente ai privati qualsiasi forma di trasmissione radiofonica. Chi violava questa norma rischiava il sequestro delle apparecchiature e pesanti sanzioni penali.
Eppure, nella prima metà degli anni Settanta, qualcosa iniziava a muoversi. Il primo caso di pirateria radiofonica in Italia fu Radio Sicilia Libera che iniziò le sue trasmissioni in onde medie il 24 marzo 1970 per sole ventiquattro ore (prima dell’arrivo dei Carabinieri) nella zona terremotata della valle del Belice. Fu Danilo Dolci, il sociologo e attivista, a dare vita a questa esperienza pionieristica: una radio per dare voce agli ultimi, per raccontare la tragedia del terremoto che aveva devastato la Sicilia occidentale due anni prima.
Speaker – Autore: 100 PASSI MEDIANETWORK
Due anni dopo, nel 1972, Giuseppe “Peppo” Sacchi, ex regista RAI, fonda Telebiella, sfruttando una lacuna del Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che non prevedeva l’ottenimento di concessioni televisive per la televisione via cavo. Telebiella viene registrata come “giornale periodico a mezzo video” e rappresenta la seconda esperienza televisiva privata italiana, dopo Telediffusione Italiana Telenapoli.
Il precedente del cavo: la sentenza 225/1974
Il primo vero colpo al monopolio arriva il 10 luglio 1974. La sentenza della Corte Costituzionale n.225 del 10 luglio 1974 permise ai privati di trasmettere esclusivamente via cavo e in ambito locale, aprendo la strada alla nascita delle prime emittenti indipendenti. La Corte dichiara il divieto assoluto per i privati una violazione dell’art. 21 della Costituzione (libertà di espressione): la trasmissione via cavo locale non interferisce con il servizio pubblico nazionale e, dunque, non giustifica il monopolio statale.
Questa decisione, nata dal caso di Telebiella e dalla battaglia legale condotta da Sacchi insieme al pretore Giuliano Grizi, apre una prima breccia nel muro del monopolio. Le trasmissioni via cavo sono libere, purché locali.
I pionieri dell’etere: le radio “pirata” del 1974-1976
Tra la sentenza del 1974 e quella del 1976, l’Italia vive un biennio di fermenti sotterranei. Chi ha il coraggio di sfidare la legge inizia a trasmettere via etere, andando oltre le concessioni del cavo. Si tratta delle cosiddette “radio pirata” che poi saranno chiamate “radio libere”, un fenomeno tipico degli anni Settanta.
Nascono esperienze come Radio Milano International (oggi Radio 101), Italian Broadcasting Corporation, la toscana Radio Studio X. Sempre a Milano nacque Radio Popolare, tuttora esistente, fondata nel 1976. Molte di queste emittenti operano in una zona grigia legale, consapevoli del rischio ma determinate a rompere il silenzio dell’etere monopolizzato.
A Bologna, come vedremo nel dettaglio del Capitolo 1, nel novembre 1974 la “Radio Bologna per l’accesso pubblico” di Roberto Faenza e Rino Maenza anticipa temi e modalità che saranno poi centrali nell’esperienza di Radio Alice.
Nel frattempo, dalle frontiere arrivano segnali diversi: trasmettendo fuori dai confini italiani (ma con una serie di ripetitori in territorio italiano tale da poter essere ben ricevuta in buona parte della penisola italiana) l’emittente diffondeva i suoi programmi anche in Italia su scala nazionale, erodendo così l’allora vigente monopolio TV. Telemontecarlo, TV Koper-Capodistria e la Televisione Svizzera di lingua italiana dimostrano che alternative alla RAI sono possibili e desiderate dal pubblico.
La pressione dal basso: 400 radio in attesa di legalità
Quando la Corte Costituzionale si pronuncia nel luglio 1976, la situazione è già esplosiva. Nella stessa sentenza si dà atto che le emittenti già attive in Italia sono circa 400. Quattrocento radio che trasmettono nell’illegalità, aspettando una decisione che sembra inevitabile.
La pressione viene da più fronti: dai pretori che si rifiutano di applicare sanzioni anacronistiche, dai cittadini che chiedono pluralismo informativo, dai movimenti politici e culturali che vedono nella radio uno strumento di democrazia diretta, da imprenditori che intravedono nuove opportunità commerciali.
28 luglio 1976: cade il monopolio
La sentenza della Corte costituzionale 28 luglio 1976, n. 202 affermò il principio della non invocabilità della limitatezza delle frequenze per quello che riguarda le trasmissioni in ambito locale. È la fine del monopolio RAI sull’etere.
La Corte stabilisce che il monopolio statale delle radiocomunicazioni è legittimo solo per le trasmissioni nazionali, mentre per quelle locali non sussistono le ragioni tecniche ed economiche che lo giustificano. L’etere locale deve essere libero.
Con la storica sentenza 202 del 28 luglio 1976, scardinò l’ormai insostenibile monopolio dell’emittente pubblica nell’esercizio dell’attività radiotelevisiva via etere. È una decisione epocale, che alcuni definiscono “sentenza-legge” per la sua portata innovativa.
L’esplosione: da 400 a 2.800 in due anni
La reazione è immediata e travolgente. Favorito dall’assenza di una regolamentazione specifica e dalla diffusione di apparecchi radio portatili a transistor, tra il 1976 e il 1978 il numero di queste emittenti passò da circa 150 a oltre 2.800, determinando una profonda trasformazione nel panorama radiotelevisivo italiano.
È l’esplosione delle radio libere: emittenti che nascono dai centri sociali, dai circoli politici, dalle parrocchie, dai gruppetti di amici, dalle iniziative imprenditoriali. Il carattere “libero” non si riferiva soltanto alla mancanza di concessione ufficiale (prima delle regolamentazioni successive alla sentenza n. 202/1976 della Corte Costituzionale), ma anche alla volontà di rompere con la comunicazione verticale e istituzionale della RAI.
Le radio libere introducono rivoluzioni comunicative: telefonate in diretta, dediche musicali, trasmissioni in dialetto, coinvolgimento diretto degli ascoltatori nella creazione dei contenuti. I punti di forza delle radio libere, rispetto al gestore pubblico, erano invece la possibilità di utilizzare tecnologie nuove come la stereofonia (in questo precedettero la stessa Rai) e l’interattività con gli ascoltatori.
Due anime, una libertà
Già da subito si delineano due anime del movimento delle radio libere:
1. L’anima politico-culturale: radio che nascono dai movimenti, dai collettivi, dalle realtà di base. Vogliono dare voce a chi non ce l’ha, sperimentare comunicazione orizzontale, rompere la verticalità dell’informazione di stato. Radio Alice a Bologna, Radio Città Futura a Roma, Radio Popolare a Milano rappresentano questa linea.
2. L’anima imprenditoriale: radio che vedono nel nuovo mercato dell’etere un’opportunità commerciale, ispirandosi al modello americano delle radio commerciali. Molte delle emittenti milanesi seguiranno questa strada, trasformandosi in futuro in network nazionali.
Ma nel 1976, anno zero della libertà radiofonica, queste distinzioni non sono ancora nette. Quello che conta è che l’etere è finalmente libero, e migliaia di voci possono finalmente prendere la parola.
Verso il racconto
È da questo scenario che nasce il nostro viaggio. Un viaggio che inizia dalle roulotte sui colli bolognesi, passa per gli appartamenti romani dove si inventano nuovi linguaggi, attraversa le officine occupate torinesi, esplora gli esperimenti milanesi, tocca le esperienze coraggiose del Sud.
Il 1976 è l’anno zero non perché prima non esistesse nulla, ma perché da quell’anno tutto diventa possibile. Le radio libere non nascono dalla sentenza, ma trovano in essa la condizione giuridica per esprimersi. Il loro spirito, però, è già vivo da tempo: nelle sperimentazioni clandestine, nelle battaglie legali, nei sogni di comunicazione orizzontale.
E questo spirito – quello delle radio “libere ma libere veramente”, per citare Eugenio Finardi – merita di essere raccontato, esplorato, tramandato. Perché non è mai stato solo una questione tecnica o giuridica. È sempre stato un fatto di voce, di accesso, di possibilità.
La storia che iniziamo a raccontare è la storia di quella possibilità che, dal 1976, ha cambiato per sempre il modo di fare e ascoltare radio in Italia.
segue in: CAPITOLO 1 – BOLOGNA: LA ROULOTTE BIANCA E IL SEME DELLA LIBERTÀ
Collaborazioni Transmediali
Quando la lettura diventa creazione condivisa
Questo articolo ha ispirato nuovi contenuti e collaborazioni. Un ringraziamento speciale a chi ha trasformato la lettura in un’esperienza creativa condivisa, arricchendo il dialogo attraverso diverse forme mediali.
💡 La magia della transmedialità: ogni medium porta la propria voce unica al racconto collettivo, creando un ecosistema narrativo più ricco e sfaccettato.

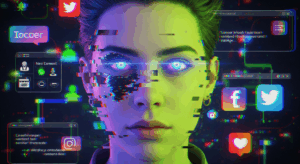


2 thoughts on “INTRODUZIONE: 1976 – L’ANNO ZERO DELLE RADIO LIBERE”
Comments are closed.