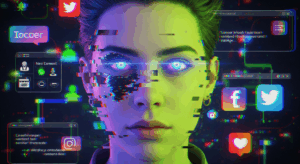Aprire varchi, generare reti.
Reading Time: 6 minutesQuesto articolo esplora esempi storici e attuali di transmedialità autentica — quella che non si limita a espandere un brand, ma apre mondi, connette linguaggi e coinvolge il pubblico in modo attivo. Dai franchise come Star Wars e The Matrix alle esperienze alternative di Devo, Wu Ming e Napoli Mon Amour, fino ai progetti partecipativi come gli ARG, Donnie Darko e Città di Frontiera: un viaggio dentro la narrazione che attraversa i media e invita a riscrivere le mappe.
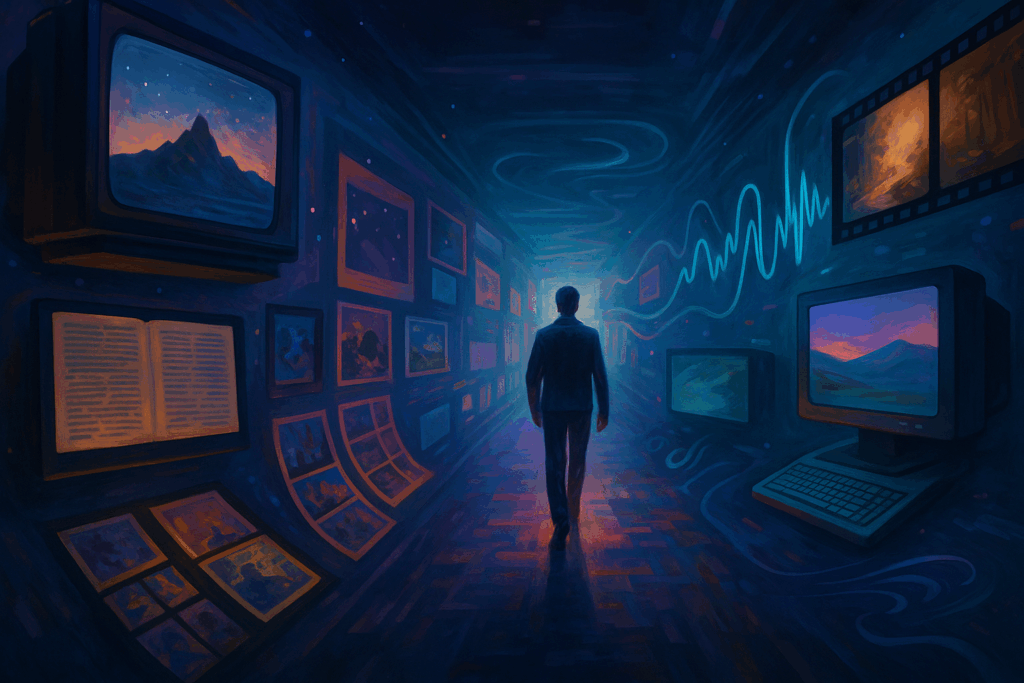
Oltre la parola d’ordine
Transmedialità: tutti ne parlano, pochi la praticano davvero. E quando la praticano, spesso è solo una replica, un’espansione del brand, un videogioco fatto a tavolino o un account TikTok che ricalca i contenuti del film. Ma noi cerchiamo altro.
Cerchiamo quei casi in cui la transmedialità non serve solo a promuovere, ma a raccontare di più. Quando l’universo narrativo si apre come una porta, e non come una trappola.
Dal consumo all’esplorazione: quando la storia prende altre strade
Quando attraversare un videogioco, una graphic novel, un podcast o una serie significa scoprire nuove zone d’ombra della storia, nuove voci, nuove prospettive. Quando il pubblico non è più consumatore ma esploratore, e la storia non si esaurisce in un solo media ma si moltiplica, si arricchisce, prende strade impreviste.
Non ci interessa la transmedialità che fidelizza. Ci interessa quella che sorprende. Che connette. Che lascia spazio.
Perché alla fine è tutto lì: in quella voglia di raccontare e di ascoltare senza limiti.
Di scambiare storie, immagini, suoni, visioni. Di costruire mondi che non si chiudono con un finale, ma che restano aperti come una mappa ancora da esplorare.
1. Dal franchise alla frontiera: casi mainstream che ci hanno sorpreso
Qui non ci interessa snobbare il pop, anzi: ci interessa quando il pop riesce a superare sé stesso.
Quando un prodotto commerciale si trasforma in una porta d’accesso per immaginari più ampi, dove le regole del gioco si fanno più complesse e coinvolgenti.
- Star Wars (Lucasverse): all’inizio era “solo” un film di fantascienza, ma si è trasformato in un mondo aperto e stratificato.
Oltre alla saga cinematografica principale, esistono decine di romanzi, fumetti, videogiochi, serie animate, enciclopedie online e fanfiction. Alcune di queste espansioni hanno semplicemente ripetuto la formula, ma altre — come la recente serie Andor— hanno esplorato lati più oscuri, politici, esistenziali dell’universo, spostando lo sguardo sui personaggi secondari e sul contesto sociale.
Non più solo Jedi e Sith, ma ribellione, precarietà, controllo, quotidianità dell’oppressione. - The Matrix: i quattro film (la trilogia originale più Resurrections) sono solo una parte del puzzle. Ci sono i corti animati di Animatrix, che raccontano storie parallele e approfondiscono la mitologia del mondo. C’è il videogioco Enter the Matrix, che si intreccia con gli eventi dei film e offre nuovi punti di vista.
Ma soprattutto, c’è una chiave di lettura che le stesse sorelle Wachowski hanno condiviso col tempo: Matrix come metafora dell’esperienza transgender, del passaggio, della trasformazione identitaria. Un’interpretazione che ha trovato risonanza profonda in molte persone trans e queer, perché parla di corpi, sistemi che ti definiscono, scelte radicali di liberazione.
E c’è — ancora di più — la partecipazione attiva del pubblico, che ha trasformato l’universo narrativo in una riflessione collettiva su tecnologia, identità, realtà e illusione. In un’epoca dominata dal digitale, Matrix è diventato un linguaggio condiviso. - Twin Peaks: qui la transmedialità diventa quasi una forma di ossessione.
La serie originale degli anni ’90, il film Fire Walk With Me, il ritorno del 2017 (The Return) e tutti i materiali accessori — il diario di Laura Palmer, le cassette di Dale Cooper, i libri fittizi scritti dai personaggi — compongono un universo narrativo che non dà mai tutte le risposte.
Ogni nuovo supporto apre un’altra domanda. Ma non è solo questione di moltiplicare i contenuti: è una precisa scelta stilistica e filosofica.
Twin Peaks è un’esperienza aperta, disturbante, profondamente sensoriale.
Gli elementi transmediali non servono a spiegare, ma a confondere, destabilizzare, mettere in crisi le aspettative del pubblico. Le musiche di Angelo Badalamenti, le fotografie sfocate, gli oggetti di scena che ritornano sotto altre forme: ogni dettaglio è parte di un mondo che funziona secondo logiche oniriche, affettive, intuitive.
Un mondo in cui il tempo non è lineare, e la verità è sempre sfuggente. Anche per questo Twin Peaks ha generato una delle community più longeve e attive del panorama televisivo: forum, fan theory, fanzine, remix, video-saggi. Ogni spettatore diventa interprete, investigatore, a volte co-autore. La serie è finita, ma il viaggio è ancora aperto.
Un’esperienza che si espande nel tempo e nello spazio, e che continua a generare senso molto dopo la visione.
Questi casi dimostrano che, anche dentro al grande sistema dell’intrattenimento globale, esistono varchi. Sta a noi attraversarli, e decidere se restare spettatori o diventare parte attiva del viaggio.
2. Quando sono i margini a creare il centro: transmedialità alternativa
Qui le storie nascono in frizione, non in produzione. E la transmedialità è frutto di resistenza, desiderio, visione. Non ci sono grandi budget o strategie di mercato: ci sono idee che si muovono da un medium all’altro perché vogliono sopravvivere, comunicare, connettere.
- Devo: non solo band, ma collettivo multimediale fin dalla fine degli anni ’70. Hanno prodotto cortometraggi satirici, manifesti teorici sulla “de-evoluzione”, performance dal vivo con costumi iconici e videoclip visionari. Hanno inventato un’estetica, un mondo, un linguaggio che anticipava la distorsione digitale, l’alienazione da algoritmo e la crisi dell’identità nell’era dei media. Chi entra nel mondo Devo non ascolta solo canzoni: esplora un archivio visivo, filosofico, narrativo.
- Wu Ming: gruppo di scrittori italiani che ha rinunciato alla firma individuale per costruire una narrazione collettiva.
Ogni libro (da Q a L’invisibile ovunque) è solo una tappa: attorno ci sono blog, spettacoli, reading, inchieste, dossier, podcast e partecipazioni a eventi dal basso.
È una delle esperienze più solide e longeve di transmedialità critica in Italia. Ogni medium è usato per approfondire, riscrivere, rilanciare le domande. Niente viene chiuso in un formato definitivo. - Napoli Mon Amour (film + romanzo + rete indie): caso raro e prezioso. Il romanzo di Alessio Forgione parte dai margini: un libro minuscolo, laterale, personale. Ma diventa film (con la regia di Guendalina Zampagni) e il film a sua volta si intreccia con la scena culturale napoletana contemporanea. Librerie indipendenti, proiezioni itineranti, reading e dibattiti: un ecosistema nato quasi spontaneamente, che parla di disagio, amore, città, gioventù, senza filtri. È la transmedialità dei piccoli miracoli: quando qualcosa riesce a toccare corde profonde e si propaga senza bisogno di permessi. (film + romanzo + rete indie)*: un caso più recente, dove un piccolo romanzo underground diventa film, e il film diventa una chiave per leggere una generazione e una città, grazie a un ecosistema culturale che connette librerie, cinema, attivismo.
3. Quando il lettore diventa nodo: partecipazione e riscrittura
Il salto di qualità avviene quando lo spettatore smette di essere target e diventa nodo narrativo. È qui che la transmedialità diventa davvero coinvolgente, non solo perché cambia chi racconta, ma perché cambia cosa può essere raccontato, e come.
La narrazione non è più un flusso a senso unico, ma un campo aperto dove l’interpretazione, la partecipazione e l’invenzione collettiva diventano parte stessa del mondo narrato.
- ARG (Alternate Reality Games) come I Love Bees (legato al lancio di Halo 2) o Year Zero (progetto dei Nine Inch Nails): esperienze in cui il pubblico non si limita a ricevere informazioni, ma è chiamato a decifrare messaggi nascosti, partecipare ad eventi, risolvere enigmi e spesso collaborare in rete.
La storia si diffonde tra siti web fittizi, telefonate automatiche, oggetti nel mondo reale.
E il confine tra realtà e finzione si dissolve. Il mondo narrativo dipende da chi vi entra, e cambia con le sue azioni. - Donnie Darko: film cult diventato portale di ossessioni condivise.
Dopo l’uscita, i fan hanno invaso forum, creato diagrammi temporali, elaborato teorie esistenziali. Il sito ufficiale, costruito come un labirinto a enigmi, offriva nuove chiavi di lettura attraverso quiz, documenti, file segreti.
Tutto era immersivo. E nel tempo il film è diventato qualcosa di più: una piattaforma emotiva e speculativa in cui ogni spettatore scrive la propria versione della storia. - Città di Frontiera: progetto in divenire, dove la mappa è aperta, e ogni ascoltatore/utente può contribuire, spostare l’asse, generare altri punti.
Un archivio narrativo, una rete audio-geografica che cresce con chi la attraversa.
Qui la transmedialità non è un accessorio, ma il cuore stesso dell’esperienza.
Ogni nodo aggiunto è un gesto narrativo, ogni mappa costruita è anche una dichiarazione di poetica, di politica, di presenza
Un progetto che inseguo sin dal 1989.
Questi esempi mostrano che una narrazione condivisa non si limita a parlare con il pubblico: ci parla attraverso di lui. E non c’è nulla di più potente.
L’esempio di Città di Frontiera, già descritto sopra, lo conferma: ogni mappa costruita diventa una forma di racconto, ogni nodo una presa di posizione. È proprio in questi gesti che la transmedialità trova la sua dimensione più viva e collettiva.
Transmedia non è marketing, è mappa per evadere
La vera transmedialità è quella che non sai dove ti porterà. Quella che non è pensata a tavolino per fidelizzare, ma che nasce dal desiderio di attraversare linguaggi e mondi.
È una lotta contro la semplificazione, contro l’algoritmo che ci conosce troppo bene. È un atto di libertà.
Non vogliamo solo seguire una storia: vogliamo viverla, riscriverla, contaminarla.
Transmedialità come pratica viva e imprevedibile
Transmedialità non è un’etichetta da appiccicare su un prodotto, ma una pratica viva, una tensione, un invito a costruire legami inaspettati. È una forma di esplorazione, e come ogni esplorazione degna di questo nome comporta rischi, deviazioni, bivi e sentieri invisibili.
Significa abitare il confine tra i media, tra i codici, tra le discipline. Ma anche tra le persone. Perché ogni storia, per funzionare, ha bisogno di essere accolta, distorta, trasformata da chi la ascolta. In questo senso, la transmedialità è una forma di ospitalità radicale.
Non ci interessa solo parlare attraverso i media. Ci interessa parlare con, contro, oltre.
E allora che sia chiaro: transmedia sì, ma con il coltello fra i denti. E con la mappa ben aperta sul tavolo, pronta per essere riscritta insieme.
Nel prossimo articolo entreremo ancora più a fondo nel processo: proveremo a capire come si costruisce da zero un racconto transmediale.
Quali sono gli elementi fondamentali, le scelte da fare, gli errori da evitare. Non una guida rigida, ma un kit di strumenti aperti per chi ha voglia di immaginare storie che si muovono tra i media come correnti sotterranee. E che non hanno paura di cambiare forma, voce, traiettoria.